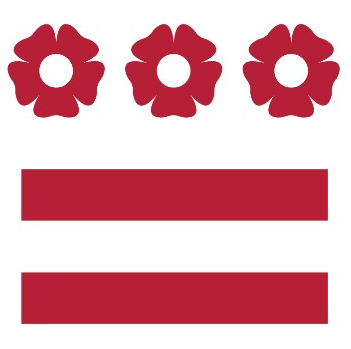NUM : zattera in mezzo al mare all’orizzonte dell’Era dell’intelligenza artificale

foto a cura Luca De Nardo per Art & Glamour Magazine
Tra gli argomenti più in voga, a cui assistiamo inermi ascoltando i media alla televisione, alla radio, al computer o sul nostro cellulare, riecheggia come un disco rotto l’avvento dell’era dell’Intelligenza Artificiale, denominata “AI”, nella consueta abbreviazione anglofona che genera l’inversione dell’aggettivo, anteposto al sostantivo “Intelligenza”. Diversamente da quello che succede nella lingua italiana, ove l’aggettivo segue il nome quando ha una funzione restrittiva e lo precede se ha una funzione descrittiva.
La lingua inglese in tutta Europa e nel mondo, dal dopoguerra in poi, è entrata nella nostra vita, soppiantando il francese e, ancor prima, il latino. Questo fenomeno, apparentemente solo linguistico, che ha superato ormai tre quarti di secolo, non è solo una questione di moda ma una importante trasformazione, una sorta di traghetto da uno stato delle cose ad un altro, specchio di una coscienza e un metodo nuovo di tradurre, guardare, vivere, ascoltare, ricordare ed elaborare, ben oltre dinamiche generiche nazionaliste o stataliste. La lingua si apprende sin dalla più tenera età ed è la massima parte della complessa tessitura delle proprie relazioni, della propria vita, dinamica e complessa, al tempo stesso. In poche parole, la lingua è la lente d’ingrandimento con cui guardiamo il mondo. E l’inversione dell’aggettivo, piuttosto che del sostantivo la dice lunga. La scelta di racchiudere in due vocali “A” e “I” il futuro di un mondo migliore, più comodo, più sicuro perché fuori dalla portata dell’uomo, dall’errore e della sua dicotomia tra il male ed il bene se, da un lato, rassicura, come l’avvento della lavatrice, della lavastoviglie o della prima teleferica o del primo treno telecomandato, dall’altro, preoccupa per il rischio di perderne il controllo.
Ecco che l’esercizio del libero arbitrio, da potenziale bagaglio informatico, via via integrabile, della più performante Intelligenza Artificiale, ci attrae, ma genera anche il timore di scoprire, in formato robotizzato, la parte peggiore dell’istinto umano. In sintesi, abbiamo paura di noi stessi, di quella parte più egoista ed autodistruttiva, e il dubbio che il nostro sostituto, l’alter ego A.I. possa essere sprovvisto di quella umanità, che gli antichi chiamavano pietas. Tutti ascoltiamo, più o meno interessati o assuefatti, nella convinzione che questa fantomatica Eradell’A.I. ci travolga a pieno o possa, egoisticamente, riguardare solo le generazioni future, non riscuotendo così, in certi casi, un vero e concreto interesse.
Lasciamo così che i nostri sensi, tra cui la vista e l’udito, si lascino trasportare in un’azione quasi passiva di accoglimento della notizia, come la scuola primaria del grande schermo dell’era post-moderna. Alcuni, i più temerari, si spingono a trattare l’argomento in spensierate serate a tavola o in un salotto gremito di amici, i più volenterosi a fare conferenze e persino biennali d’arte, come la prima Edizione della Biennale di Arte Internazionale Contemporanea dell’Albania a Durazzo ad ottobre 2024 o il Festival delle Filosofie di Palermo alla sua settima edizione. Ma cosa preoccupa tanto?
Il nocciolo del problema risiede proprio nella perdita della coscienza umana. La coscienza figlia di secoli e secoli di storia che non finisce mai di crescere e di espandersi, errando, correggendo e riassestando il colpo di generazione in generazione, senza mai dare per compiuta la lezione della vita. Ma in cosa consiste la coscienza umana, come possiamo racchiudere il pensiero e l’indole umana in un unicum, anche solo metaforico, permettendoci una licenza poetica? Credo che la principale fonte della coscienza umana, simile ad un fiume in piena, sia la storia, il patrimonio culturale dell’uomo, le arti, la scienza, la musica, la letteratura e anche la tecnologia. Nasce come un insieme di ruscelli che alimentano lo stesso fiume che non si arresta mai e che continua a produrre ed a riprodursi.
Ma il connotato comune alle varie “piattaforme” di discussione, che siano monologhi o dialoghi, pubblicazioni o conferenze, è la sensazione di un palpabile concreto distacco teorico nell’avvertire la questione come un intangibile problema pratico.
Necessitiamo di sedicenti miti moderni o delle dichiarazioni allarmanti di capi di governo per prendere la questione più seriamente e, colti da un leggero sobbalzo, lasciarsi solleticare dal brivido di paura. Dopo una manciata di secondi, però, torniamo alla nostra vita di sempre e declassiamo il problema. Perfino il rischio dell’esercizio di un potere concreto di simultaneo uso di testate nucleari in tempo di guerra, il nostro tempo, non ci fa concretamente paura perché il nostro immaginario vede la sua realizzazione, se pur possibile, lontana e solo teoricamente futuribile.
In realtà, siamo già immersi nell’Era dell’Intelligenza umana artificializzata, surrogata e sintetizzata, come il concentrato racchiuso in un piccolo tubo di pomodoro, dentro una grande scatola che emula i nostri nervi cranici, motori, sensitivi e misti in un labirinto di cavi.
E così la piattaforma di discussione si trasforma in una sorta di zattera, in balia di un mare sempre in tempesta, ove le onde sono le notizie, le informazioni che da ogni dove ci rivelano tutto ed il contrario di tutto, rimbalzando da ogni parte del globo, dilatando le nostre umane ventiquattrore in duecentoquaranta ore, impossibili da digerire e da metabolizzare.
A questo punto, cari lettori, mi perdonerete se scelgo la metafora della zattera, figura cardine e cornice del cuore delle riflessioni di questa nostra rubrica di inizio estate, un pavimento flottante di fortuna, composto da grosse travi di legno, unite da fragili cime per salvare il genere umano. Se da un lato, per ironia e diletto nel non prendersi troppo sul serio, rammento l’iconica raffigurazione di una coppia solitaria in mezzo al mare, all’ombra dell’unica palma rimasta delle barzellette della Settimana Enigmistica, dall’altra desidero introdurvi nella “dialettica” dell’arte, ma soprattutto della ricerca che può essere alla base della professione dell’artista, nel passato come nella nostra contemporaneità. L’artista nel vivere il suo tempo, si muove su un pentagramma di emozioni che lo portano, in certi casi anche inconsapevolmente, ad anticipare paradigmi, incognite e problematiche future, a tratti impersonificando le anticipazioni di una moderna Cassandra, come epiloghi o conseguenze di futuribili di fatti storici. La sua opera può illustrare stupore, meraviglia ma anche preoccupazione o denuncia di qualcosa che non approva o che velatamente teme possa accadere, come la La città che Sale di Umberto Boccioni.
Si può dire che la lungimiranza accomuna molti artisti del passato con quelli di oggi e quelli che verranno dopo di loro, intesa come una sorta di capacità di anticipare i tempi e le conseguenze degli accadimenti annunciati. Si pensi al legame stretto ed indissolubile dei futuristi ad inizio secolo, incantati dagli effetti dell’elettricità sulla vita quotidiana, dalle macchine ai primi tram ed ai primi ascensori. L’innovazione ha ispirato gli artisti a dare un’immagine persino al rumore del motore a scoppio e del pistone, per tradurre l’effetto meccanico motrice dell’energia termica, generata dalla combustione di una miscela di carburanti ed aria come la Velocità e luci di Giacomo Balla
Altri, invece, hanno preferito restituire ai posteri nelle loro opere, il senso di paura e di precarietà che anticipa l’avvento di una nuova tecnologia, l’eventualità di una scelta sbagliata e delle conseguenze derivanti da essa, tra i pro e contro.
Facciamo dunque astrazione e lasciamo che le onde della fantasia cullino i nostri pensieri. Abbandoniamo l’Oceano atlantico e puntiamo alla foce della Senna, tra Trouville sur Mer e Deauville, nella Normandia francese. Risaliamo, controcorrente, il fiume, tra una chiusa e l’altra, e giungiamo all’Ile de la Cité, nel cuore di Parigi.
Scendiamo dalla nostra zattera immaginaria super confortevole, genere bateaux mouches, comprando diligentemente in anticipo un biglietto sulla piattaforma informatica del Louvre. Superiamo le file, visto che l’intelligenza artificiale ce lo ha permesso, ed andiamo dritti dritti verso le sale dell’800 francese per salire sulla grande zattera del pittore, Théodore Géricault , uno dei massimi esponenti del romanticismo francese: Le Radeau de La Méduse.
Si apre a noi la visuale di una gigantesca zattera di ben 35 metri quadrati, distribuiti in quasi cinque metri per sette metri, o poco più, dipinta su lino, molto diversa da quella confortevole che abbiamo appena lasciato.
Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault
Inorriditi, come ospiti occasionali, ci barcameniamo tra carni umane di un gruppo di antieroi, uomini senza gloria, vittorie o medaglie, trasformati in attori protagonisti di una storia di cronaca del loro tempo, il 1816. Sono i pochi sopravvissuti ad un naufragio annunciato, quanto prevedibile, di un Francia in piena espansione coloniale, sulle coste al largo della Mauritania. In questo quadro l’artista celebra la condizione umana, qualunque ne sia l’origine o il ceto sociale: la tragedia della presunzione e dell’errore umano.
Il soggetto qui è la carne umana. Corpi semi nudi e vestiti a brandelli, non c’è posto per orpelli, gioielli, monete, libri, coppe, forzieri o ricchezze, solo l’uomo, la carne umana, l’identità e la memoria racchiusa nelle loro menti. Come spesso accade, grazie alla capacità espressiva dell’arte, anche qui la realtà passata, presente e futura, irrompe nella nostra vista con un potere deflagrante, rendendoci l’immagine concreta dell’avverarsi di un rischio possibile che abbiamo immaginato o sminuito, voluto o non potuto evitare di correre.
La storia della nave Medusa, come del Titanic, e di tante altre opere tecnologiche dell’uomo, naufragate alla forza del destino, supera la narrativa del mancato salvataggio dell’undicesimo giorno, quando la nave Argo, all’orizzonte, pur sfiorando la zattera della Medusa, non vedendola la mancò, per poche miglia il soccorso, posticipandolo solo al suo ritorno, sulla medesima rotta una settimana dopo. In quel lasso di tempo umano, fu fatale il destino crudele di coloro che non riuscirono a sopravvivere, diventando materia prima di sopravvivenza per i pochi sopravvissuti.
Un quadro come un’opera architettonica, come una composizione sinfonica, nel momento in cui viene guardata o ascoltata, come un dialogo silenzioso tra autore e pubblico, si porta con sé la lente d’ingrandimento della vita, dell’educazione, della cultura dell’occhio dell’osservatore. Tra i milioni di osservatori del Radeau de la Meduse c’è chi vedrà o vivrà una semplice zattera, chi dei poveri naufraghi, chi dei corpi morti e altri vivi, chi neri chi bianchi, chi si rivolterà per i ruoli, più o meno eroici attribuiti ad un personaggio piuttosto che all’altro, o chi ne sarà completamente indifferente. E poi ci sarà chi, da questa immagine, così complessa nella sua composizione e nella sua compresenza di opposti assi visivi inclinati, sottesi dalle due funi e dalle estremità della zattera, avvertirà un brivido gelido lungo la schiena: il senso di precarietà ed instabilità della vita e della condizione umana.
Duecento anni dopo le prodezze di Géricault, un artista contemporaneo italiano, Federico Solmi, emigrato giovanissimo in America, della scuderia di una delle più importanti grandi collezioni di arte contemporanea al mondo, la The Phillips Collection di Washington, si cimenta nel rappresentare la sua zattera, una zattera di sei metri per tre, con a bordo numerosi personaggi mitologici dell’Era dell’Umanità, figure cardine della storia del mondo da Cesare a Napoleone, l’Imperatrice Teodosia, la Regina Maria Antonietta, Garibaldi, Platone, Aristotele, Anassimandro, Cristoforo Colombo sino ai giorni nostri Putin, Gheddafi, Saddam, Trump e tanti altri. Sto parlando dell’opera “The schip of Fools”, la nave dei folli. La zattera di Solmi è l’occasione concreta di un viaggio dentro l’arte digitale del nostro secolo, di cui l’artista è da tempo pioniere e grande interprete.
E Federico Solmi non lasciando nulla al caso, sceglie di presentare questa incredibile zattera dei pazzi in una città di mare, sospesa tra la laguna ed il cielo: Venezia. E lo fa nel momento temporale cardine del grande teatro dell’arte contemporanea, ossia durante la più importante Biennale d’arte al mondo, la 60° Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea alla Biennale di Venezia, in perfetta aderenza con il tema indicato dal curatore” Stranieri ovunque”.
The schip of Fools di Federico Solmi
Solmi, un po’ naufrago nella sua doppia cittadinanza italo-americana, diviso dall’oceano Atlantico, coglie l’occasione per sviluppare una pungente analisi ed una intrinseca critica del potere dei media e di come una ramificazione di sistemi di controllo, collegati tra loro, dalla storia passata a quella più recente si impongono alla società, portandola alla deriva. E lo fa scegliendo di non rappresentare né l’Italia, né l’America come avrebbe potuto proponendo un padiglione collaterale, ma come battitore libero da ogni catena o diritto di Stato. Federico Solmi non è un artista di Stato ma un artista dei suoi tempi, con una grande versatilità con cui ha saputo passare dall’uso dei pastelli e della pittura ad olio, dal disegno preparatorio all’uso delle sostanze acriliche e delle resine sino alla video arte. La sua specificità oggi non è più solo l’essere approdato all’arte digitale ma il procedimento in atto, direi, inverso, di restituzione pittorica di quello che accade dentro le sue tele digitali. Un reticolo di pixel e linee che reggono l’immagine ed i colori dei corpi in movimento, come moderne marionette rendono il senso antropologico e sociologico dei grandi della storia, dell’iconografia intrinseca nella decantazione delle loro gesta. Ma le gesta degli eroi del passato, dei miti, belli o brutti, buoni o cattivi, sono sempre passate per la censura o la vittoria del vincitore, filtro della Storia, della Storiografia, e, da tempo, dalla creazione del quinto potere: la stampa. In questa opera Solmi amplifica la potenza dei media e della velocità divulgativa di un non luogo, posizionato nell’Olimpo del cyber spazio, utilizzando semplicemente la luce del pastello azzurro e verde, per congiungere i tratti digitalizzati delle onde del mare alla volta celeste e ad un orizzonte impalpabile, come una nebulosa, confinando le figure mitologiche in un’eterna scialuppa di fortuna.
A pensarci bene, in questa scelta iconografica del soggetto e della loro rappresentazione, una deforme zattera di naufraghi in balia delle onde per nulla facile da rappresentare e formalmente antiestetica, Géricault e Solmi sono accomunabili anche dalla prospettiva ottica, nella quale si sono dovuti mettere o, meglio, immergere per poterla immaginare. Come visionari all’interno di quello stesso mare, con tecniche e modalità diverse, sono riusciti a rendere un orizzonte più fluido e più morbido.
L’oscillazione delle linee della prospettiva del quadro è sottesa alla fluidità delle onde del mare di entrambi gli artisti, metafora di un andare avanti ed un andare indietro, tra le pagine della storia. Ma i personaggi di Solmi, a differenza di quelli di Géricault, non sono immortalati nell’attimo in cui cercano di sopravvivere alla forza del destino.
Sono tutti già morti. Ma non la loro identità, la loro fama, il DNA della loro vita e delle loro gesta è sopravvissuto a tutto, veritiero o meno, è stato capace di attraversare i secoli, oltrepassando la sua umana esistenza.
La sua mostra è un percorso dentro la tela, espressione della video arte di oggi, utilizzando in modo inclusivo video, dipinti, sculture in ceramica, opere in realtà virtuale, ologrammi e media di ogni genere, creando un dialogo circolare tra di loro, a tratti magico, grottesco, visionario, fantastico e incredibilmente distopico. Nelle opere di Solmi la videoarte e la pittura si incontrano, manualità e tecnologia informatica si fondono, per poi essere rivelate e scoperte in una visione capace di svelare i retroscena dell’arte digitale.
L’arte digitale, figlia meticcia della fotografia, del cinema e l’arte grafica, è entrata a pieno titolo tra le diverse forme della pratica artistica. In essa vi è un uso della tecnologia digitale come parte del processo creativo che la differenzia da quella tradizionale. I pennelli ed il colore non sono derivati della natura, dalla barbabietola al lapislazzulo, come ai tempi di Giotto o di Botticelli, ma dalla capacità di gestire ed utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall’odierna tecnologia informatica e grafica. Prevale così l’emozione e la visione del messaggio dell’artista che, potrà più agilmente concretizzarsi, ben oltre le proprie capacità pittoriche, valutando come produrre e distribuire il suo contenuto creativo tra una corolla di programmi, modelli geometrici e plastici possibili.
L’arte digitale è un paesaggio vasto, una sorta di grande negozio virtuale pieno zeppo di scaffali diversi con colori e pennelli infiniti. L’infinito presente e futuro è dato dall’intreccio del metodo, la tecnica al servizio del concetto e del progetto. L’insieme di questi utensili e la combinazione degli stessi è la visione unica dell’artista, la nuova frontiera dell’arte, oltre la tela e la sua materia.
Solmi con la sua zattera, versione odissea nello spazio, crea un ponte tra la realtà pittorica e materica delle arti plastiche e quella impalpabile dell’arte digitale. Un cortometraggio artistico derivato della sequenza robotica dei personaggi delle sue opere, metafora degli Dei e dei miti del presente che sfilano in un’immaginaria processione come una sorta di parata olimpionica, oltre i confini del tempo, creando un reticolato di video, un vero e proprio film cartografico. Allo spettatore è permesso entrare tra le fibre della tela, con l’ausilio degli oculum. Da questa esperienza immersiva ne esce un po’ come un funambolo inconsapevole, un po’ intontito, con dubbi e sollecitazione nuove. Federico Solmi cattura la sua attenzione e rivela lo scheletro della nuova immagine virtuale dando allo spettatore le chiavi della sua quarta dimensione, aprendo le porte del mondo digitale sul retro verso del disegno, con la pittura e il mondo del gaming, il cinema, la vita e l’animazione.
È l’inizio di un nuovo viaggio. L’arte non finisce mai di sorprenderci e di offrire punti di vista e riflessioni nuove. L’arte è la continua sperimentazione di un linguaggio capace di rinnovarsi in aderenza con la realtà, risultando sempre nuovo, giovane nella sua contemporaneità, per poi entrare nella storia e dare il passo a futuri e futuribili fenomeni linguistici. Mai come in questo secolo, la tecnologia è entrata nell’arte e nel modo di fare arte e, obbligatoriamente, ha incrementato il suo dizionario. E quando parliamo di dizionari ed enciclopedie, non possiamo prescindere dall’ “alfabeto” le cui lettere, una volta assemblate, compongono le parole, i suoni ed i pensieri dell’uomo.

Dopo avere incorniciato la “”zattera dell’umanità”, in alcune delle sue declinazioni più curiose, in un’estate che stenta a partire e prendere il vento, non posso resistere alla tentazione di parlarvi di “Nûn”, la gigantesca imbarcazione concepita e disegnata dal grande architetto navale e designer Aldo Cichero, classe 1944.
Nûn, un nome ed un destino, come suggerisce la celebre locuzione latina, nomen omen, racchiudendo in sé il significato di un’opera architettonica ed ingegneristica, di uno dei più grandi progettisti della storia della nautica mondiale, vincitore di numerosi premi internazionali, capace di superare i meri canoni estetici e ingegneristici navali e proporre una grande “zattera” futura, un superyacht di 120 metri, concettualmente capace di raccogliere la testimonianza e la complessa eredità del passaggio dell’uomo sulla terra. Un museo galleggiante, abitato da opere d’arte, capace di dare il senso e la traccia della produzione millenaria dell’umanità in una visione atemporale.
Il progetto di questo incredibile transoceanico yacht è di per sé un grande concept, con diverse potenziali forme di realizzazione che racchiude in sé diverse e convergenti grandi sfide: – realizzare un natante di dimensioni ciclopiche rispettoso della natura e non inquinante;
– racchiudere il meglio dell’arte umana;
– renderla materialmente fruibile a tutte le coste del mondo;
ed infine,
– preservarne il DNA nel caso in cui l’umanità dovesse estinguersi.
La prima sfida realizzata da Cichero più di un decennio fa mira alla realizzazione di un super yacht altamente tecnologica sul piano meccanico ed energetico, direttamente proporzionale alla sostenibilità ambientale della sua andatura. In poche parole, il grande architetto, celebre per la sua visione interdisciplinare applicata alle sue forme progettuali, ha disegnato uno scafo in ogni suo particolare, mirando all’autosufficienza energetica, proponendo una economia circolare all’interno del natante stesso, in grando di tenere conto delle potenzialità presenti in mare, nel corso della navigazione. Il traguardo che si era preposto era l’autonomia di crociera e la contemporanea emissione zero di idrocarburi e di inquinamento atmosferico e acqueo. Ha così progettato i primi alberi retraibili e vele solari per poter ottimizzare al meglio due elementi, il sole ed il vento convertendoli in energia potenziale, in base alle necessità. Con il piano velico di questo prototipo, Cichero ha combinato la classica propulsione diesel – elettrica e/o ad idrogeno con generatori di energia provenienti dal moto ondoso, che circonda la carlinga della nave. La sua opera è una delle prime progettualità al mondo che ha introdotto pratiche ecosostenibili e tecnologie, ottimizzando ed implementando la gestione energetica, non solo con i pannelli solari ed i generatori eolici ma proponendo soluzioni innovative che tengano conto dell’estetica del luogo e della volontà di salvaguardare la bellezza del pianeta dagli abissi del mare sino alla punta dell’albero maestro.
Non si vive di sola energia, tra le possibili andature di crociera, Cichero ha voluto valorizzare anche la bellezza della natura e portarla a bordo per una migliore ossigenazione dello spazio in movimento, oltre che decorazione neorinascimentale dello stesso. E così ha proposto un’area di suolo vegetale che non è ha diretto contatto con il suolo naturale.
Con sapiente consapevolezza, figlia di una saggezza e di anni di esperienza tra architettura navale e terrestre, ha abbandonato la mera funzione scenografica di quello che potrebbe essere definito il giardino pensile flottante, comunque innovativo per la sua epoca, per guardare anche qui ad una funzione circolare di riciclo di preservazione di un ambiente, sano e totalmente autosufficiente nella creazione e riproduzione di materie prime vegetali per la sopravvivenza della specie umana. Ha così predisposto delle vere e proprie terrazze, ossia dei veri e propri strati vegetali collocati su supporti strutturali impermeabili, utilizzando il riciclo di materiali non biodegradabili, e asserviti ad un complesso sistema di giardini pensili dotati di irrigazione artificiale, attraverso la simultanea desalinizzazione e conversione dell’acqua del mare in acqua potabile, generando un microclima terrestre flottante sul mare. La genesi di questo complessa del progetto racchiude in sé la rielaborazione e lo studio di grandi della storia, tra governatori, architetti e urbanisti del passato dal re babilonese Nabucodonosor II, in assoluto il primo che ebbe l’idea di rinverdire i tetti del suo palazzo come anche gli antichi Romani, abili costruttori di giardini pensili, come il famoso mausoleo di Augusto del I sec a.c. o la Villa di Tivoli dell’Imperatore Adriano nel II sec d.c., di cui possiamo ancora ammirare gli eleganti Cipressi che hanno resistito ai millenni di storia umana e naturale.
La cultura dei giardini pensili ha, però, una lunga storia, in particolare nel Rinascimento, basti pensare ai sontuosi giardini del palazzo di Guido di Montefeltro ad Urbino o ai giardini di Palazzo Piccolomini a Pienza come ai giardini di Villa Madama a Roma, al Giardino dei Boboli a Firenze o all’orangerie di Versailles ed ai terrazzamenti del fontaniere Bernini, fratello del celebre scultore, a Villa Barbarigo di Valsanzibio nei Colli Euganei.

Ma per restare in tempi più recenti, ossia al XX secolo, gli architetti che più hanno rimodulato la funzione primariamente di protezione del soffitto della domus, da ogni intemperia proveniente dal cielo, in funzione di una promozione ecologica oltre che di estetica sono certamente Von Rabitz, Gropius, Frank Lloyd Wright, Roberto Burle Marx, Ernesto Basile, Le Courbousier, Henri Sauvage, Friedensreich Hundertwasser tra i tanti.
Non potendo apprezzabilmente parlare di tutti i grandi scienziati dell’architettura che, con occhio artistico ed innovativo, nelle loro diverse piccole e fondamentali pratiche, hanno saputo valorizzare il mondo vegetale nella vita dell’uomo, trasmettendone il valore della salvaguardia oltre che dell’utilizzo nutritivo, scelgo di riportare le parole di Le Corbusier “Il tetto giardino restituisce all’uomo il verde, che non è solo sotto l’edificio ma anche e soprattutto sopra”. Ma senza spingersi nello studio dell’architettura dei grandi del passato, nel silenzio delle culture africane, sudamericane, delle isole transoceaniche, tramandate nei millenni, senza fama e senza gloria, rinveniamo in villaggi dimenticati e dispersi nei meandri del mondo la buona pratica di umili abitazioni, per lo più capanne, modestamente ricoperte con piote di terra ed erba.
La visione di Cichero si differenzia, però, da coloro che lo hanno preceduto concentrandosi nell’estetica delle diverse forme di conversione funzionale dei tetti, focalizzandosi su una prospettiva unica: ripopolare di verde quanto più possibile sia stato sottratto alla terra in costruzioni in pietra, marmo, paglia o calcestruzzo.
Nel caso di Nûn il tetto, i balconi, le balaustre e anche gli interni, aggiungono crosta umana artificiale e quindi ossigeno e sintesi clorofilliana alla preesistente crosta terrestre, generando terre “emerse” dalla creatività visionaria di un grande architetto che ha saputo fare tesoro dell’esperienza umana della scienza delle costruzioni, unendola alle altre scienze come l’arte, la navigazione, l’agronomia, la botanica, l’ingegneria, l’arte, la sociologia, l’antropologia, l’astronomia e la scenografia con umiltà ed ingegno. Nun si trasforma così in una zattera di salvezza non tanto di lusso, come il connotato super yacht certamente auspica, ma un paradiso terrestre flottante, una zattera non della salvezza, alternativa ad una barca caduta a picco ma un concentrato del sapere dell’uomo capace di racchiuderne il benessere in senso globale, di vivere e di qualità della vita.
La seconda e la terza sfida di Nûn è di concepire il primo grande museo galleggiante e di renderlo materialmente fruibile, facendolo approdare in tutte le coste del mondo. L’idea di un museo galleggiante, pronto a salpare, per custodire e rendere concretamente visibili le opere più importanti della storia dell’umanità, permettendo a tutti di visitarla ad ogni suo approdo. Toccare con mano l’opera, vederla dal vivo, incardinerebbe come una sorta di tendenza controcorrente rispetto all’era digitale della scannerizzazione e riproduzione 3D. Valorizzare la copia originale potrebbe essere la vera sfida.
Questo obiettivo porta in grembo una doppia finalità, ossia la democratizzazione reale dell’arte e la prevenzione della sua distruzione, salvaguardandola in caso di guerra o di cataclismi annunciati. Una specie di Arca di Noè dove oltre all’umanità, il mondo animale e vegetale, si pensi di portare via la migliore produzione artistica di tutti i tempi, per non dimenticare il nostro passato perché parte della nostra memoria.
Da un lato lo spostamento delle opere all’interno di una nave museo diffonderebbe il beneficio della sua materiale contemplazione relegando, al giusto posto di surrogato, la mera riproduzione virtuale. D’altro canto, la possibilità di allocare le opere d’arte in nicchie sicure, dotate di sensori basculanti al volteggiare delle onde, in previsione dell’oscillazione dei basamenti, comporterebbe la possibile migliore salvaguardia di opere d’arte, dall’archeologia alla più recente arte contemporanea, in caso, non proprio peregrino, di rischio di scoppio di un conflitto armato mondiale.
Come suggerito proprio da Aldo Cichero, Nûn potrebbe essere un galleria d’arte “eco friendly” a cui potrebbero concorrere tra le file dei più generosi filantropi, come possibili attori, non solo i classici collezionisti d’arte che già di fatto addobbano i loro super yacht con opere d’arte di valore, ma rete di Stati, parte di continenti o in una visione più ottimista, del mondo intero, che potrebbero accordarsi per creare uno o più musei flottanti capaci di concentrare alcune opere iconiche della produzione artistica rappresentative della storia dell’arte, universalmente parlando.

Nûn oltre che una grande nave si tramuterebbe in una sorta di ideale ponte tra le culture, ove il pubblico potrebbe sperimentare senza ostacoli geografici, il potere dell’arte: un potentissimo mezzo di comunicazione, una forma di linguaggio che non conosce frontiere e barriere di sorta, se non quelli dei limiti ideologici della censura temporale.
Ma non gridiamo troppo alla vittoria perché ci troviamo pur sempre nell’Era della clonazione da quella delle pecore a quella delle opere d’arte, sino a quella umana della diffusione del metaverso. Inoltre, per mettere d’accordo tutti i Ministri della cultura ed i Soprintendenti di tutte le Regioni e gli Stati coinvolti, potenziali prestatori di opere, dovremmo attendere anni ed anni, affrontando mille difficoltà, per ottenere i numerosi scarichi di responsabilità, generati dall’onerosità del costo dell’assicurazione per ogni opera.
Ecco che la tecnologia ci arriverebbe in soccorso, risolvendo i molteplici giustificabili problemi, sostituendo le opere con il clone in scala reale, sosia autentica, dell’opera originale attraverso un multiplo realizzato nei materiali più disparati, dai più preziosi ai più biodegradabili, rendendo fruibile l’estetica e l’iconografia dell’opera d’arte, piuttosto che la sua concreta autenticità.
Questa impostazione potrebbe essere particolarmente interessante per la capacità di raccogliere e preservare, non si sa mai (!), il DNA di ogni opera, ossia la scannerizzazione in altissima definizione delle grandi opere d’arte, classificate come il patrimonio immateriale dell’umanità che, a scelta, potrebbero addirittura essere realizzata in modo virtuale con una proiezione oleogrammatica verticale, superando ogni barriera logistica o allocativa, perché frutto di una visione ottica controllata che non graverebbe nemmeno di kg sul peso della barca.
Ma le prime tre funzionalità, intrecciate tra loro, ci fanno riflettere all’ultima finalità possibile, quella più provocatoria, che partendo da un ipotesi apocalittica , ad onore del vero, è all’origine di questo progetto di super yacht ossia la creazione di un nuovo mondo, senza esseri umani che ha condotto il grande architetto Aldo Cichero a ideare Nûn, quando ha concorso nel 2016, alla selezione del bando interdisciplinare della Biennale di Arte Contemporanea Internazionale a Palermo, la Bias.insititute.
Idealmente Nûn rappresentava la proiezione artistica di una ipotetica nave fantasma, seconda solo all’epica Arca di Noè, in cui il tema della creazione veniva intimamente legato al come e dove partire per creare un nuovo mondo. L’animo artistico di Cichero, con ghigno ironico, mosse i passi della sua ricerca non dalla rappresentazione di una creazione astrattamente possibile ma dalla certezza di una distruzione del mondo e dalla gestibilità di una creazione, astrattamente parlando, di un mondo senza uomo che ne preservi l’integrità ed identità delle sue gesta, solo quelle buone s’intende.
Abbandonando così l’Era dell’antropocentrismo, “l’umanità” di Cichero non merita di salire sull’arca di Noè di questo secolo. Dobbiamo immaginarci, cosi uomini come carne umana abbandonata in cima al molo, sulle rive del mare, lungo le spiagge come zattere questa volta terrestri mentre implorano ad una “saggissima” intelligenza artificiale di salire e di salvarsi che, potendo scegliere, opta per il male minore: lasciare l’animale più parassita della terra a terra, avendo orami appreso con la massima certezza che solo l’arte potrà salvare il mondo.
ﻥ
Giunti ormai al termine di questo brevissimo viaggio, a vele spiegate, bordati dalla cornice del mare, finalmente, vi svelo il mistero del nome di questo super yacht. Nûn non è un nome scelto a caso ma la fonetica di una lettera sia dell’alfabeto arabo che di quello ebraico. In quello arabo Nûn conclude la prima parte dell’alfabeto, composta da ventotto lettere, posizionandosi al quattordicesimo posto con il valore numerico cinquanta. Mentre nell’alfabeto ebraico Nûn è al ventiduesimo posto. In entrambe le tradizioni è molto più di una lettera. Ricorda infatti la forma di una balena, accordandosi d’altronde con il senso originario della stessa parola nûn che significa pesce. È composta infatti dalla metà inferiore di una circonferenza con al centro un punto, come una grande arca galleggiante sulle acque. Il punto è il germe dell’immortalità, il nucleo nascosto del DNA dell’umanità indistruttibile che sfugge a tutte le dissoluzioni esterne.
Nûn è molto di più di un progetto virtuale navale, è una lettera in mezzo al mare, capace di ricongiungere idealmente la storia passata a quella presente, creando un ponte per il futuro dell’umanità. Da un lato l’antichità di una lettera di due culture antichissime, sopravvissute alla storia, nate e cresciute nella medesima area geografica della terra, quello che oggi definiamo il medio-oriente, tra il Sinai, la Giordania e la Cisgiordania, emblema di due culture spesso in lotta tra loro.
Il nome del grande battello scelto da Cichero non è casuale. È l’essenza massima del progetto capace di racchiudere la sintesi della storia umana, con una incredibile opera di comunicazione e di agglomerazione tra i popoli, nella navigazione dello stesso mare della vita.
Due lingue, l’ebraico e l’arabo, che trascinano al suo interno la gioia ed il fardello di una nazione e, al tempo stesso, oggi spesso confuse nella loro logica identitaria di due religioni: ebraica e musulmana.
Il pittogramma del pesce, Nûn, non è solo una lettera ma anche l’oceano primordiale della tradizione mitologica dell’antico Egitto che Cichero ripropone nell’archetipo delle balconate dei giardini pensili in stile babilonese.
Nûn porterebbe così dentro di sé il germe dell’immortalità, del migliore concentrato dell’identità umana, abbandonando il suo stato individuale e predatorio, per svilupparsi spiritualmente in un ambiente cosmico di resurrezione ove la nuova nascita presuppone, necessariamente, la morte del precedente stato, che sia di un individuo o di una comunità intera.
Morte, nascita o resurrezione, sono aspetti inseparabili di una medesima essenza, poiché non sono in realtà che le due facce opposte di uno stesso cambiamento di stato.
Nûn indica il processo stesso della creazione associando la mente che crea (l’oceano) e il creato (il pesce) nel suo processo di vita e di morte; è la necessità della metamorfosi e del cambiamento. Così Nûn diviene oggetto di ripensamento della vita, del suo senso ultimo di ciò che noi vorremmo salvare di noi stessi e del nostro mondo, se domani iniziasse un nuovo diluvio universale. Quali pensieri, parole vorremmo portare con noi, con cui costruire il nostro nuovo mondo; cosa salveremmo della presente umanità?
Potrebbero accompagnarci alcune opere d’arte, come fossero lo scenario per una nuova avventura? Cosa pensiamo possa avere un valore fondativo. Ma forse potremmo rinunciare a tutto per lasciare che il diluvio crei dentro di noi un grande spazio vuoto, dove nuovamente possa emergere una vibrazione, un suono, una lettera, con cui ricominciare a scrivere una storia, magari più rispettosa della natura di questa incredibile madre Terra che ci ospita.
Porto Rotondo, 30 giugno 2024
Chiara Modìca Donà dalle Rose